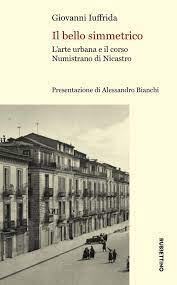(11/2/23) Giovanni Iuffrida è un architetto, uno studioso, uno storico, che, come ho avuto modo di dire più volte, ha lavorato nell’ufficio tecnico del comune di Lamezia invece che all’interno di una università, ma questa a me pare solo, per adoperare il titolo di un film recente, una semplice “Stranezza”. Nel 2004 scrisse con lo storico Saverio Di Bella “Di terra e di mare…” e fu quel volume che mi consentì finalmente di capire per quale ragione noi calabresi che viviamo in una terra circondata dal mare siamo interiormente “montanari” e non “marinai”, al contrario dei liguri che come noi vivono in un contesto appenninico simile. In altre parole, se un calabrese vuol capire le ragioni storiche che non ci hanno consentito di amare il mare e vivere in prevalenza con il turismo marinaro, sul quale è basata invece l’economia ligure, quel libro fornisce tutte le spiegazioni del caso.
Adesso Iuffrida con “Il bello simmetrico” (Rubbettino, 2022) consente a noi lametini, in particolare ai nicastresi, di comprendere diverse cose che spiegano “come eravamo” e “come siamo diventati”. Questo testo è un saggio specialistico e tocca agli studiosi di urbanistica e di architettura recensirlo. Io proverò invece a raccontare i pensieri che ha generato ad un nicastrese come me che, per caso, si è trovato a fare le vasche tutta una vita lungo corso Numistrano e che negli anni sessanta giocava in quella che è oggi “via dei Giardini”, oppure a via Pasquale Celli detta “Arreti ’i feri” (dietro le Fiere). Questo libro avrei voluto leggerlo in quegli anni perchè il corso lo abbiamo sempre considerato “un gioiello” ma oggi finalmente Iuffrida, spiegandoci come si è sviluppata la città di Nicastro, ci insegna che trattasi di “bello simmetrico”.
Una rivoluzione e un salto culturale straordinario per Nicastro, l’alternativa allo spontaneismo architettonico, dal quale è derivato un gusto, in relazione alla percezione quantomeno visiva di un ordine.
“Ancora oggi nei prospetti di corso Numistrano si legge l’emanazione di un obbligo etico, un messaggio di disciplina, di decoro urbano. Il bello simmetrico non era più accademia ma un risultato concreto, il privato rimaneva confinato soltanto all’interno delle mura domestiche. L’esterno di ogni edificio era pubblico più che privato e ci si sentiva in dovere di replicare i dettagli più semplici, come le ringhiere dei balconi, le aperture anche delle costruzioni, perchè si sentiva il bisogno di far parte di quel noi, noi, noi che era diventato qualcosa di un più semplice dettaglio edilizio. E’ la costruzione del senso di comunità, meglio, della bellezza del senso di comunità”.
Provate oggi ad un privato di imporgli, chessò, il colore delle abitazioni e la riterrà manifestazione di una dittatura. Oggi che noi lametini viviamo scambiando nella discussione collettiva quasi sempre la parte per il tutto, la symmetria ci mostra il principio dell’intelligenza che rapporta la parte con il tutto mediante l’armonia della proporzione.
Iuffrida ci conduce per mano (nelle parti del libro che un non specialista come me riesce ad assorbire) per valutare il “ruolo della mente creativa collettiva nella costruzione del bello simmetrico”. La rivoluzione urbana di Nicastro nei primi decenni del 19° secolo si sviluppò in un territorio che non solo conosceva le calamità naturali, terremoti e alluvioni, ma anche il colera, attribuito nell’Ottocento alla malvagità dei governi (vi ricorda qualcosa?).
LA CITTA’ LUOGO SICURO Attraverso la lettura di questo bellissimo saggio si intuiscono meglio le necessità politiche di Lamezia nella misura in cui si approfondisce la sua storia. L’ordine segue al caos, ma abbiamo capito che noi rispondiamo al caos solo quando lo provoca la Natura (terremoti, alluvioni). Il caos urbanistico e amministrativo di Lamezia, provocato dalle scelte degli uomini, non ci disturba. Ma, mi chiedo, non dovrebbe (oggi che disponiamo di tecnica e di un cervello tecnologico) la politica locale avere una sola unica idea intorno alla quale costruire le policy? E qual è questa idea se non quella di Bernardo Secchi, la città deve essere un “luogo sicuro, protetto dalla violenza della natura e degli uomini”. Ogni città grande e piccola dovrebbe amministrarsi per proteggere i propri abitanti dalla violenza. Le politiche antimafia non devono combattere la prepotenza esercitata dalle cosche sugli imprenditori? E in luoghi ad alta intensità sismica non dovremmo, come fanno in California e in altre nazioni civili, prepararci quotidianamente ai terremoti che verranno, nei territori franosi in cui abbiamo costruito non dovremmo ogni giorno pensare a come difenderci dalle piogge? A tutto, ma proprio a tutto pensiamo (pinzillacchere le chiamava Totò) tranne che alla prevenzione, ai rischi sismici e geomorfologici.
“Perchè l’insistenza a rimanere ancorati a quella località?”, chiede ad un certo punto Iuffrida, e risponde con un’altra domanda: “ Affetto, abitudine, cultura, o lo stretto rapporto con l’invisibile e il sublime? L’eccezionalità degli eventi naturali rappresenta l’ineluttabilità, come la morte, che capita una volta sola”.
IERI E OGGI Insomma, questo libro consente finalmente di chiarire meglio come una popolazione capace di fare del corso Numistrano, “il segno urbanistico, il contenitore di forme architettoniche, l’espressione di maggiore civiltà e bellezza della città di Nicastro” sia stato capace di ridurlo ad un deposito di auto in doppia fila. E giunti al 2023 i veri pazzi farebbero ricoverare chi dice che bisognava renderlo pedonabile già da almeno 30 anni.
Un’ultima utile osservazione ci consente di capire che tutto si tiene, che nessuno si salva da solo, che il territorio si governa, come la salute, senza confini, che il localismo o il municipalismo sono fenomeni politici arretrati e miopi. Mai prima del secolo XVIII Nicastro è stata minacciata dalle acque del torrente Piazza e solo dopo la fondazione di Platania, all’incirca nel 1688, iniziarono i disboscamenti e le conseguenti alluvioni. Quello che succede a monte avrà conseguenze a valle e tutti i comuni che procedono in ordine sparso, così come le regioni, sono la causa di tutto ciò che non funziona.
E siamo arrivati così al pensiero illuminante di questo libro prezioso, la frase che dovremmo ritagliare per scolpirla nelle nostre teste ma anche su qualche muro o sul marmo :
“Insomma, una città bella deve essere tale agli occhi di chi la guarda e nella qualità della vita che consente di sviluppare, come fatto individuale e collettivo. Non può essere bella una città se non funziona”.
LE CITTA’ BELLE FUNZIONANO Nelle belle città si vive meglio e quando uno si accorge di non stare vivendo bene vuol dire che la città è diventata più brutta. Quello che tanti riducono a semplice estetica ha a che fare con l’armonia del funzionamento. In effetti basta aprire un orologio per vedere come funziona il suo complesso meccanismo e il concetto lo capisce anche un bambino, quel meccanismo è bello e funzionante. Se non funziona, è solo inutile ed assomiglia ad un groviglio.
Dimenticavo. Lo stupendo corridoio architettonico oggetto di questo studio sarebbe più corretto chiamarlo, secondo l’archeologo francese Lenormant, piazza o Strada Maggiore, piuttosto che corso Numistrano. Numistro è un’antica città del nord della Lucania (nei pressi di Muro Lucano) e non ha niente a che vedere con Nicastro.
appendice
BARACCHE E’ un viaggio nel tempo affascinante ma anche desolante perchè uno capisce subito che nella storia di Nicastro nei secoli tornano sempre gli stessi temi. Prendiamo il termine “baracche” che da almeno 30 anni noi intelligentoni moderni non sappiamo dove spostare dal campo profughi di Scordovillo che ci siamo sistemato al centro della città. La notte del 10 dicembre 1782 il torrente Piazza a causa dell’ostruzione del suo letto in corrispondenza del ponte d’ingresso alla città, inondò quella che un tempo era questa piazza grande, in tutta la sua estensione, compresa la parte abitata. Nello stato di emergenza cominciò la realizzazione di baracche diffuse, come primo ricovero degli abitanti e così la piazza grande si trasformò in una città di legno.
Nell’ottobre del 1816, subito dopo la riconquista del regno, venne disposta la demolizione di queste baracche costruite sul suolo pubblico “perchè rendevano deforme la pubblica piazza”. L’ultratrentennale uso di quelle baracche, alcune delle quali trasformate con opere di muratura, lungo quella fila di pioppi che divideva la piazza in due (la piazza superiore da quella inferiore, o lorda, delle erbe) venne messo in discussione però tanti tentarono di conservare il privilegio di restare nel luogo deputato storicamente al commercio, di usufruire della centralità urbana e soprattutto dello stretto rapporto con il percorso extraurbano verso Catanzaro e la Marina di S. Eufemia.
13/6/1810 Gli abitanti di Nicastro compresi Fronti e Platania alla data del 13 giugno 1810 erano 7895, con ben 37 preti, 10 cappuccini, 3 domenicani, 9 riformati. Non si conosce il numero degli oziosi e dei vagabondi. I benestanti, proprietari non travagliatori, erano 192. I più danarosi erano le famiglie Ippolito, Statti e Stella.
Ai pioppi si sostituirono le case, in una operazione spontanea senza sforzi intellettuali, ma furono il luogo, lo spazio, la memoria a progettare quello che ci è stato tramandato. E’ il corso Numistrano, che divenne il luogo più identitario della nostra citta’, in cui tutti i cittadini ci riconosciamo: non è immaginabile la città senza il suo corridoio urbano più prestigioso. Vivendo ormai in un “non luogo” soltanto al corso Numistrano appartiene la nostra identità. Che Dio ce lo conservi per sempre e tenga lontani i barbari. Senza questo corso, modificandolo, distruggendolo, perderemmo tutto, la nostra storia e la nostra memoria.
DOPO IL CAOS L’ORDINE “Dopo le calamità naturali, la bellezza non può essere intesa come dicotomia tra tradizione e caos, ma come ordine, almeno formale”. La simmetria è la risposta al caos degli eventi naturali. In quel frangente il desiderio di una città pubblica, di ordine, igiene, benessere collettivo, insomma il bisogno di una città degna di tale nome, furono obiettivi di tutti, poveri e benestanti condannati dai terremoti e dalle alluvioni e anche dal colera. C’era insomma la necessità politica di dare risposta all’esigenza di una rifunzionalizzazione commerciale della città, nel luogo storicamente riconosciuto per questa destinazione, la piazza grande.
LA PIAZZA GRANDE La piazza grande è, sino al XV secolo, un informe vuoto urbano, destinato prevalentemente alle pratiche ortalizie a ridosso dei tre corsi d’acqua Piedichiusa, Canne e Piazza. Dunque questo spazio è in realtà un grande invaso, esito di un punto di confluenza idrico intorno al quale cresce lentamente la città. E’ il luogo privilegiato d’incontro di commercianti con le loro mercanzie.
Il bello agli inizi dell’Ottocento come regola di costruzione della città assurge a vero protagonista assoluto ed inequivocabile. Gli edifici devono assicurare l’uniformità perchè l’occhio non sia disturbato da anomalie ingiustificate. Ci deve essere un colpo d’occhio rasserenante e con un spirito originale ben distinguibile dagli altri spazi pubblici (strade e piazze).
SALVATORE AMENDOLA Il primo a dare inizio e a concludere la costruzione del proprio fabbricato (facente parte della linea centrale che divide in due la piazza grande) è Salvatore Amendola, commerciante positanese da molti anni domiciliato a Nicastro. La sua casa diventa unità di misura del “bello simmetrico”, in un contesto che vede la chiesa di san Domenico circondata dalla borghesia commerciale e dal potere emergente del brigantaggio, con il sovrastante palazzo Panedigrano del noto bandito Nicola Gualtieri, molto vicino ai regnanti Borbone, e la linea di fabbricati nella zona di maggior prestigio, che va da palazzo Fiore sino al palazzo d’Acquino e da qui, in doppia fila, a palazzo d’Ippolito, per proseguire sino a palazzo Mancini.
LA DISUNITA’ URBANA Dopo l’Unità d’Italia il completamento edilizio attuato “paradossalmente segna la fine del bello simmetrico e l’inizio della disunità urbana”. Altezze e numero dei piani diversi, dal rigore formale alla libertà espressiva, la più ampia ed eterogenea possibile. “La parabola discendente, una sorta di inquinamento estetico che prende il sopravvento sulla città di Nicastro e ne corrode la memoria” è cominciata con la Repubblica.
LE ORIGINI L’origine della storia contemporanea della città di Nicastro è l’insediamento di Torrevecchia. Il torrente Piazza ha ispirato la localizzazione dei primi insediamenti umani sul versante nord della piana di S. Eufemia, ha progettato la città, se si guarda agli elementi della geomorfologia, molto più di quanto abbiano fatto gli uomini e ha determinato, lentamente, con insistenza e tenacia naturale, la nascita del protagonista architettonico principale e contemporaneo, corso Numistrano.
I TORRENTI I due torrenti, Canne e Piazze, che scorrono per i lati di questa città, animando le macchine idrauliche, ed irrigando i giardini di agrumi e di verdure diverse, sono parte integrante, inscindibile della storia di Nicastro. Nel 1852 lungo il corso del Piazza si contavano ben 26 mulini. A poca distanza, il centro abitato di Sambiase nasce sul punto di innesto del torrente Cantagalli con la pianura alluvionale. Anche la toponomastica indica la simmetria, Calìa è sinonimo di Bella, due toponimi disposti specularmente sull’asse del torrente Piazza. Nel tempo, località Calìa deve aver dimostrato che, proprio in quel punto, la terra è movitina per la faglia, fenditura naturale di origine sismica che l’attraversa.