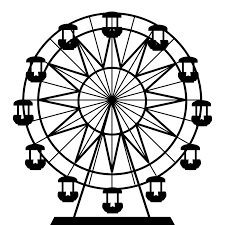Cominciamo dai nomi per poi passare alla mission. Un partito lib-dem potrebbe essere guidato da Luigi Marattin o da Giorgio Gori. Nel suo gruppo dirigente oltre Calenda e Renzi, Carfagna, Gelmini e Moratti ci potrebbero essere Irene Tinagli, Enrico Morando, Giachetti, Cottarelli, Bentivogli. Evito di enumerare le teste di uovo che da Alessandro De Nicola a Tito Boeri e Roberto Perotti sino a Francesco Giavazzi sono ben presenti nel dibattito pubblico con una incisività riconoscibile da decenni. Il compito che gli uomini di buona volontà hanno è quello (per dirlo con le parole di Carmelo Palma) “di contestare e di contrastare l’egemonia culturale bipopulista e di risvegliare dal sonno dogmatico un’Italia politicamente instupidita e analfabetizzata dalla democrazia del Gratta-e-Vinci smerciata da agenti del caos e venditori di miracoli”.
Ciò che in Italia vince e comanda oggi è un distillato di disprezzo per i fondamenti stessi dell’Occidente politico: per l’universalismo dei diritti e la tolleranza, per il libero mercato e la società aperta, per un’idea non parassitaria e discriminatoria di equità, e per un concetto non poliziesco e inquisitoriale di giustizia.
Qualunque mostro politico abbia attraversato il cielo di questo scorcio di inizio millennio – da Putin a XI JinPing, da Trump a Chavez, da Frage a Bolsonaro – ha trovato in Italia beniamini entusiasti e estimatori sinceri.
Pensavamo, dopo l’11 settembre, che solo l’islamismo – un prodotto straniero – e la paura della morte potessero istigare alla sottomissione e al ripudio di sé. Abbiamo scoperto, in Italia, ma non solo, che ci sono prodotti politici autoctoni, come il sovranismo e il populismo, e viltà molto meno confessabili capaci di generare una sottomissione ancora più incondizionata, un odio di sé ancora più profondo e un’abiura ancora più servile.
Da dove partire, allora, in questo progetto di costruzione di un soggetto e di un progetto liberaldemocratico? Da Orwell: dal legame inscindibile tra verità e libertà e tra menzogna e oppressione e dalla consapevolezza che senza la riabilitazione democratica dell’Italia – di tutta l’Italia – non basta certo la supplenza dei seri, dei competenti e delle persone perbene per cambiare il corso degli eventi, come dimostra la gloriosa e triste storia del Professore Draghi a Palazzo Chigi.
Serve insomma un partito che, partendo da chi ci crede, si apra a chi è disposto a ricredersi e che non si rassegni, neppure per stanchezza, al modello superfisso, quella fallacia economica perfettamente descritta da Sandro Brusco 16 anni fa (lo trovate su questo blog) che può tradursi, con lo stesso meccanismo, in una fallacia politica e che presuppone la natura rigida e immutabile sia della domanda che dell’offerta, sia dei bisogni che dei fattori produttivi, cioè – per stare all’oggetto del nostro discorso – sia di quello che la gente vuole che di quello che la politica deve darle, per guadagnarne il consenso.
Il nesso tra verità e libertà lo hanno trattato in due articoli sul Corriere il politologo Panebianco e il giornalista Verderami.
ANGELO PANEBIANCO Non c’è nessuna democrazia che ne sia davvero immune. Sono però vizi che in Italia, da tempo immemorabile, si manifestano con particolare forza. Possiamo definirli «il pendolo fra realismo e demagogia» e «la tirannia del breve termine». La matrice è comune, le cause sono le stesse.
Il pendolo fra realismo e demagogia comporta talvolta un passaggio del testimone fra chi ha vinto le elezioni e chi le ha perse. Spesso (anche se non sempre) chi vince e va al governo si cambia rapidamente di abito. Fino al giorno prima si comportava da opposizione irresponsabile, con dosi massicce di demagogia e promesse irrealizzabili agli elettori. Approdato al governo ammaina le bandiere della fase precedente, diventa realista, si sforza di apparire responsabile, consapevole delle difficoltà e dei margini di manovra ristretti che incombono sull’azione del governo. Chi perde le elezioni fa il tragitto contrario. Va comunque detto che alla buona salute di una democrazia servirebbero, anziché il pendolo, governi realisti e opposizioni responsabili, ossia opposizioni capaci di proporre ricette altrettanto realiste, anche se, ovviamente, diverse da quelle del governo.
Il secondo vizio, «la tirannia del breve periodo», colpisce soprattutto i governi. La democrazia, di per sé, tende ad essere schiacciata sui tempi brevi: l’orizzonte temporale di chi governa non va al di là delle future elezioni. E se le campagne elettorali — nazionali, regionali, locali, europee — si susseguono continuamente l’orizzonte temporale si restringe ulteriormente. Ciò incide sull’azione del governo, la rende di corto respiro: non posso preoccuparmi di ciò che accadrà fra qualche anno, devo giocarmela qui e ora.
FRANCESCO VERDERAMI L’altro elemento distorsivo del dibattito al Senato sulla guerra in Ucraina è stato l’assenza di realismo che rischia di incrinare il rapporto con l’opinione pubblica. Utilizzando la retorica della pace (obiettivo a cui ovviamente tendere) si è nascosta la comune consapevolezza che il conflitto non sarà destinato a terminare in tempi brevi. È come se la politica volesse deresponsabilizzarsi invece di assumersi il compito di far comprendere al Paese la verità della situazione: il fatto cioè che le difficoltà continueranno. Le voci dissonanti nella maggioranza testimoniano che su uno dei principali temi d’indirizzo non c’è chiarezza. E che l’intesa dovrà essere testata quando le prove si faranno più difficili. In ogni caso non è un buon viatico, visto che non sono passati nemmeno quattro mesi dalle elezioni.
Quanto all’opposizione, il profilo tardo-pacifista dei Cinquestelle che accusano i loro avversari di essere agli ordini di Washington, sollecita una domanda: cosa sarebbe accaduto oggi se a palazzo Chigi si fosse trovato Giuseppe Conte? È un interrogativo che si pongono molti (non tutti) nel Pd.